|
Ci passo davanti, ogni tanto, e sempre mi volto a guardare il portone. Lo faccio con gli edifici che hanno segnato la mia vita: l’appartamento in cui abitavo da bambina, la casa dei miei nonni, che da tanto non ci sono più, eppure ancora alzo gli occhi al loro balcone come se dovessi vederli affacciati lì ad aspettarmi; la libreria dove ho lavorato per qualche tempo, che adesso è un negozio diverso. Il Classico è sempre lì, in via Duomo, con l’austero portone settecentesco di legno scuro ad accogliere chi ne varca la soglia. In realtà, io, da ginnasiale entravo dall’ingresso in via Carducci, mi era più comodo. Mi piaceva anche ritrovarmi subito a metà corridoio, svoltare a sinistra e poi salire lo scalone. Certe scuole sono più solenni di altre, il classico lo è. Ho girato da supplente un sacco di istituti, ma pochi hanno quel potere di farti immediatamente abbassare il tono di voce e farti desiderare di interloquire con un registro linguistico più elevato. Almeno fino alla consegna delle verifiche di latino, lì poi è turpiloquio libero. Sono stata per cinque anni nell’aula Trombone de Mier, medaglia d’oro al valore, ultimo banco in fondo a destra, con vista sull’ex provveditorato e con il rumore dei termosifoni di ghisa che smarmittavano come motociclette al gp. No, non è vero, al liceo sono migrata nel primo banco, avevo finalmente capito che i professori tengono d’occhio di più le ultime file. Avevo anche perso diverse diottrie sul Rocci, avviandomi a diventare il talpone che sono oggi, e da laggiù non vedevo altro che sagome confuse, un avvicinamento alla cattedra era necessario.
Ci sono tornata poche volte, da adulta, dopo la mattina dell’orale di maturità. Tre volte, molto classico come numero, non poteva essere diversamente. La prima per consegnare una domanda di supplenza, quando ancora esisteva il cartaceo e non si passava il tempo a snocciolare insulti davanti ad un portale informatico. Avevo appena avuto la folle folle folle idea, quella di passare dall’altra parte della cattedra. L’effetto di tornare nella propria scuola “da grandi” è sempre straniante, avrei voluto dare una pacca sulla spalla alla me stessa di allora e dirle: «sopravvivrai, tranquilla. E smetterai di mettere quei maglioni, finiranno anche gli anni ‘90». Sentire la campanella, poi. E ricordarsi di quando un compagno di classe l’aveva smontata e fatta suonare a sproposito. Certe cose al classico non si fanno, certo, come no. Sarà perché mi ricordo, che non riesco mai a sgridare troppo i miei allievi. La seconda volta che sono entrata al classico nell’età della ragione è stato per cantare. A dire il vero al liceo ho imparato a cantare, appartengo alla ruggente generazione che ha militato nel coro del Lagrangia, intonando i Carmina Burana e i cori delle opere sotto la bacchetta di Barbara Rosetta. Poi è successo che un po’ di anni fa le scuole cittadine si unissero in un progetto folle, quello di riportare in scena un’opera barocca, l'Agesilao Re di Sparta. All'epoca insegnavo alle medie, al mattino tutta avvolta in cento sciarpe e terrorizzata dal mal di gola spiegavo l’analisi logica e al pomeriggio cercavo di imparare le mie arie tutte piene di agilità, proprio io che di agile non riesco a fare niente, nemmeno il lavoro. Per ironia della sorte, ero andata a provare i costumi nella sartoria dell’Ipsia Lombardi, quella che ora è la scuola dove insegno (e ancora non ho smesso di imbucarmi in laboratorio per misurare quello che creano le ragazze). Per alcune prove generali dell’Agesilao ci era stato concesso l’uso dell'aula magna del Lagrangia, cantavamo recitativi barocchi tra le colonne di pietra dicendo una marea di stupidate perché si cresce sempre solo fino a un certo punto. Comunque, avrò avuto già trent’anni ma - per la miseria - a entrare lì, tra le colonne di pietra, mi sono sentita di nuovo quella familiare sensazione di terrore allo stomaco di quando la Botti sorteggiava di greco alla prima ora. Certi luoghi funzionano meglio dei cani di Pavlov. Non ci sono tornata più. Finché, vinto il concorso, non ho dovuto frequentare tra quelle antiche aule, al pomeriggio, il corso per i neoimmessi in ruolo. Siamo un buffo paese dove tu insegni per anni, poi finalmente vieni assunto a tempo indeterminato e allora sei obbligato a seguire un corso di una manciata di ore in cui ti viene spiegato come fare un lavoro che in realtà svolgi già da anni. Credo che abbiano scelto come sede il Classico proprio per la solennità di cui sopra, quella che limita gli sfoghi verbali ad un blando ball’es kórakas. mormorato a mezza voce. In quell’occasione ho ritrovato la mia scuola rimessa a nuovo, ho scoperto che l’aula di fisica non c’era più, sostituita da un moderno laboratorio di informatica. Era bella l’aula da fisica, con i banchi a gradinata. Si sarebbe copiato benissimo. Uso il condizionale perché davanti ti piazzavano sempre uno che ne sapeva meno di te, mentre i traduttori talentuosi venivano posizionati nei banchi più elevati. In effetti i PC sono più utili. Adesso poi, non ne parliamo. Passo davanti al Lagrangia, mi volto, come sempre per abitudine, e vedo attaccati ai portoni i cartelli comuni a tutte le scuole, quelli che indicano i percorsi differenziati, che contrassegnano l’entrata e l’uscita. Passare davanti alle scuole era una delle tante certezze che non ci sono più, si sente un silenzio irreale, le aule sono deserte o popolate di pochi studenti, poche classi. Passerà anche questo periodo. Pánta rheî, tutto scorre. Mi pare di averlo imparato lì dentro. Valentina Petri ex allieva del Liceo Classico "Lagrangia" di Vercelli (maturità 1996), professoressa di lettere a Vercelli e autrice del romanzo Portami il diario, 2020, ed. Rizzoli
1 Comment
|
Ex allievi Liceo Classico “Lagrangia”Un blog per raccontare il Liceo Classico "Lagrangia" di Vercelli e quanti hanno trascorso nelle aule di via Duomo anni importanti della propria formazione. Storie, interviste, approfondimenti culturali e molto altro a cura dell'Associazione ex allievi. Archivi
Giugno 2021
Categorie
Tutti
|
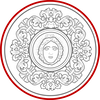

 Feed RSS
Feed RSS
